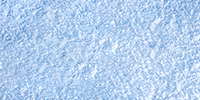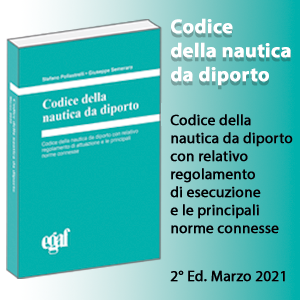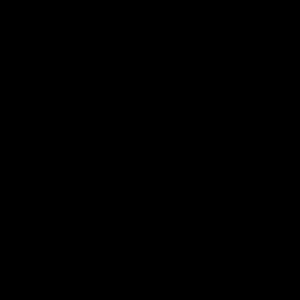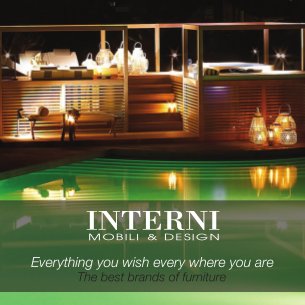Giovanni Da Verrazzano, il navigatore
che fece da ponte fra mondi diversi

Immaginate di poter far salire in cattedra direttamente la storia e di assistere all'interrogazione, fantasiosa quanto fantastica, di un alunno d'eccezione: Giovanni Da Verrazzano. È quanto ha fatto Giorgio Grosso, autore nel 2004 del libro Navigare necesse est e nel 2007 del secondo lavoro, Mal del mare, oltre che collaboratore della rivista Arte Navale, che in questo articolo ha compiuto, navigando fra storia, leggenda e fantasia, un viaggio straordinario che dal Passaggio a Nordovest arriva fino a New York... Il Passaggio a Nordovest: una via d’acqua per mettere in comunicazione due oceani, la scorciatoia ideale per superare l’ingombrante continente americano, l’utopia sognata e inutilmente inseguita per secoli dai naviganti di mezzo mondo. Eppure il passaggio c’è, l’Artico è un’isola, una grande isola circondata dal mare; ma il mare non si vede, costantemente sommerso da montagne di acqua solidificata, totalmente ricoperto da ghiacci perenni. Solo nel 1904 Roald Amundsen, a bordo di una potente nave rompighiacci, riuscì ad attraversare quel gelido ed impossibile mare aprendosi un varco fra gli iceberg e la banchisa polare. Poi, improvvisamente, dopo 100mila anni di volontario oscuramento, l’estate scorsa il Passaggio si è mostrato spontaneamente; i ghiacci si sono sciolti e il lungo canale è diventato completamente e liberamente navigabile. Non per le barchette da diporto, naturalmente, ma già si parla dell’arrivo delle navi da crociera, sempre alla ricerca di nuove eccitanti destinazioni con cui risvegliare l’interesse dei propri pigri e distratti passeggeri.
Prima di Amundsen gli inuit-thule erano già riusciti a passare da un oceano all’altro...
Per la verità qualcuno era già riuscito a passare dall’uno all’altro oceano attraverso il mare Glaciale Artico ben prima di Amundsen. Gli inuit-thule, gli antichi abitanti dell’Alaska, incominciarono ad avvertire, intorno al XII secolo, un fastidioso innalzamento della temperatura ambientale. Loro, che nel freddo ci stavano tanto bene, incominciarono a cercarlo più a nord fra i ghiacci perenni. Per affrontare i lunghi viaggi gli inuit usavano imbarcazioni del tutto particolari, di concezione e struttura quasi incredibile, ma alla fine eccezionalmente efficienti al punto da coronare con successo il tentativo di attraversamento del Mare Artico.
... attraversando il mare Glaciale Artico con gli "antenati" dei moderni gommoni
L’umiak era formato da pelli di tricheco e di foche cucite insieme e gonfiate a aria e poteva trasportare da otto a nove persone con relativi bagagli, alcuni animali vivi, accessori come tende o fornelli. Spinti da piccole vele o avanzando con i remi, gli umiak potevano procedere anche in acque profonde solo pochi centimetri e quando il ghiaccio sbarrava loro la strada, eccoli scivolare abilmente sulla banchisa, come talvolta fanno i pinguini. Così, a poco a poco, gli inuit scoprono e superano il Passaggio a Nordovest, o meglio, visto il loro punto di partenza, il passaggio a Nordest e approdano in Groenlandia dove si trovano tutt’ora.
Erik il Rosso? Fu costretto a solcare i mari perché esiliato con l'accusa di aver compiuto più omicidi
Duecento anni prima, dall’altra parte dell’Oceano i normanni avevano incominciato seriamente a pensare di affrontare il mare aperto per rincorrere “la fama, la curiosità e la ricchezza”. Dalla Danimarca e dalla penisola scandinava essi si erano spinti attraverso l’Oceano sulle tracce dei monaci irlandesi che, sorretti esclusivamente dalla cieca fiducia nella Provvidenza, si erano lasciati trascinare dai venti e dalle correnti fino ad approdare nella gelida Islanda. È in questo scenario che, intorno all’anno 1000, si collocano la figura e la saga di Erik Thorvaldsson, detto il Rosso, un poco di buono costretto a solcare i mari perché esiliato prima dalla Danimarca, poi dall’Islanda con la terribile accusa di plurimi omicidi. Erik non è il tipo da starsene con le mani in mano e per i tre anni dell’esilio solca i gelidi mari del Grande Nord con il suo drakkar, il “drago” appunto, una nave di 25 metri stretta e slanciata, con le fiancate ricoperte da scudi e dalla prua lunga e aguzza talvolta sormontata dall’effigie di un serpente per impressionare l’avversario. La navigazione verso l’ignoto è pericolosa e difficile fra iceberg alla deriva e tempeste e nebbie fitte ed egli può fare affidamento su due soli strumenti a bordo: la clessidra solare – un’asticella conficcata perpendicolarmente su una tavoletta con la quale verificare giorno dopo giorno lo spostamento dell’ombra proiettata sulla base (ma i giorni di sole non dovevano essere molti) – e un gruppo di corvi da liberare uno alla volta per intuire, dalla direzione istintiva del loro volo, la rotta giusta verso terra. Così per Erik il Rosso i tre anni dell’esilio trascorrono in fretta e gli consentono di navigare in mare aperto verso Nordovest fino ad approdare su una costa tranquilla, protetta da alte montagne, con fiumi pescosi, boschi fitti e vallate verdissime. Tanto verdi che Erik decide di chiamare questo paese così accogliente con il nome di “Terra Verde”, Groenlandia appunto. Ci sono ormai le premesse per fondarvi una colonia con fattorie ed animali e per continuare l’esplorazione verso Sud.
L’America fu scoperta per la prima volta quasi 500 anni prima di Colombo, ma nessuno se ne accorse
Una ventina di anni più tardi, proprio a cavallo dell’anno 1000, il figlio di Erik il Rosso navigherà con 35 uomini fino a una nuova terra dove cresce spontanea la vite: Vinland, quasi certamente Terranova. Erikson si spinse ancora più a Sud, fino ad arrivare all’altezza dell’odierna Boston? Non è certo, ma è sicuro che l’America fu scoperta per la prima volta quasi 500 anni prima di Colombo, ma nessuno se ne accorse. Poi, siamo all’inizio del 1200, una nuova era glaciale prese il sopravvento. La Terra Verde perse il suo splendore, le sue vallate e i suoi boschi furono ricoperti dai ghiacci perenni e il sole smise di riscaldare le pianure e le vallate. Il mare fra l’Islanda e la Groenlandia divenne impraticabile e i coloni lasciarono la Groenlandia e le loro fattorie agli inuit che, finalmente incominciarono a ritrovarsi a loro agio al punto da restarvi fino a oggi. Così delle imprese dei vichinghi e del Passaggio a Nordovest si prese a parlare sempre meno, fino a quando una nuova formidabile spinta, quella della ricerca delle spezie, non mise in movimento e in competizione il mondo intero aprendolo all’era delle scoperte.
Quando la leggenda si trasforma in storia
La storia stava prendendo il posto del mito e della leggenda. Quando si presentò al cospetto della storia, Giovanni da Verrazzano si sentì improvvisamente inquieto e nervoso. Il tono inquisitorio della prima domanda non prometteva nulla di buono: “Cosa hai fatto di così importante per essere iscritto nel registro riservato ai nostri grandi? E, attenzione – lo ammonì la storia – lascia da parte le fantasie e dimmi solo la verità, tanto noi sappiamo già tutto e quello che non sappiamo facciamo presto a scoprirlo nei nostri archivi”. Verrazzano era al corrente dell’esistenza dell’Archivio generale delle vicende umane e si rendeva conto che non avrebbe potuto esagerare nel suo racconto. “Ho attraversato l’Atlantico nel 1524 con una caravella di nome La Dauphine” esordì Giovanni, spiando nell’espressione del suo interlocutore qualche segno di approvazione. “A quell’epoca migliaia di persone l’avevano già fatto. Dimentichi forse Colombo, Vespucci, Magellano e tutti i coloni, i soldati, i conquistadores che avevano già compiuto la stessa impresa alla ricerca dell’oro e delle spezie. E comunque, perché hai attraversato il grande oceano e cosa cercavi?”. Verrazzano, che incominciava a sentirsi a disagio, si rinfrancò schiarendosi la voce: “Ecco, a differenza di tutti gli illustri colleghi che tu hai citato, io mi sono diretto a Nord. Vedi - disse con un po’ più di coraggio, aprendo la celebre carta di Waldseemuller - ai miei tempi tutti pensavano che l’America fosse un continente che si estendeva quasi completamente a Sud dell’Equatore, mentre si riteneva che le terre a Nord fossero le propaggini della Cina. Che si trattasse del Cathay o meno, doveva pur esserci a Nord un passaggio che consentisse di raggiungere l’India e le isole delle spezie più agevolmente e più rapidamente di quello scoperto dal pur eccellentissimo Magellano che ci impiegò ben tre anni, rimettendoci quattro navi e lasciandoci lui stesso la pelle”. La storia fece finta di non ricordare che Giovanni Caboto aveva visitato Terranova fin dal 1497 e sorvolò sulle ancor più antiche scorribande di Erik il Rosso e di suo figlio su quelle coste. “Vedo qui che il viaggio da Dieppe a Capo Fear durò 50 giorni, senza alcun incidente né alla nave né ai 50 uomini dell’ equipaggio che tornarono tutti a casa sani e salvi: certamente un buon risultato, ma ci vuol altro per entrare da Noi. Comunque, una volta toccata terra, cosa hai scoperto?”.
Verrazzano? Fu il primo a gettare le ancore nella baia di Hudson...
“Navigammo per circa tre mesi lungo quella costa, fermandoci per due settimane in una zona che per la bellezza delle sue campagne e le dolci planizie chiamammo Refugio, incontrando uomini di colore bronzeo, dagli occhi vivaci e dai capelli scuri chiamati Narragansett che ci fornivano spesso segni di amicizia, anche se dovevamo essere sempre molto prudenti. Poi proseguimmo sempre verso Nord in mezzo a mille fiordi, fino alla Nova Scotia e all’Arcadia, dove capii che il Nuovo Mondo non si congiunge né all’Asia, né all’Africa, ma forse alla Norvegia o alla Rossia. Da lì ci dipartimmo per tornare a casa”. La storia lo aveva ascoltato in silenzio e non sembrava tradire alcuna emozione dal suo racconto limitandosi ad aggiungere: “Capisco che tu ti sia trovato bene a Narragansett, che oggi si chiama Rhode Island: è lì che molto tempo dopo la tua visita, gli americani hanno sfidato per più di 100 anni il resto del mondo in una gara fra barche a vela che hanno chiamato, appunto Coppa America, vincendola sempre”. Giovanni educatamente non fece trasparire il suo stupore nell’apprendere che la gente potesse trastullarsi in una gara fra caravelle, anziché preoccuparsi di trovare l’acqua dolce e di preservare le gallette dagli assalti dei topi. Proseguì dunque, sparando la sua prima cartuccia. “Il 24 marzo ho scoperto un istmo che separava La Dauphine dal mare amplo: si vedea dalla nave il mare orientale, mezzo tra occidente e settentrione. Era senza dubbio quello che circuiva l’estremità dell’India e della Cina. Navigammo a lungo alla ricerca di uno stretto per poter penetrare quelli felici lidi del Cathay, ma senza trovarlo”. “Mmmmh! - sussurrò la storia scrollando il capo - tu hai semplicemente costeggiato la lunga e sottile striscia di terra da Cape Lookout fin quasi alla Virginia, oltre la quale si estende la laguna di Pamlico Sound, profonda anche 70 chilometri: altro che Oceano Pacifico!”. Verrazzano deglutì per la cantonata che aveva preso, ma aveva in serbo un pezzo da novanta: “Il 17 aprile 1524 trovammo un posto molto gradevole situato in mezzo ad alcune erte collinette fra le quali scorreva fino al mare una gran corrente d’acqua. Con una barca risalimmo il fiume e incontrammo la gente del posto che, piena di letizia e coperta di piume di uccelli di vari colori, ci mostrava come approdare con la barca nel modo più sicuro lanciando alte grida di ammirazione nei nostri confronti. In questo posto così piacevole e ospitale che offriva ancoraggi molto ben protetti dal vento, verrà costruita una grande città, una delle più grandi e importanti del mondo”.
... e a mettere piede là dove un giorno sarebbe sorta la Grande Mela
“È vero", ammise la storia, "tu sei stato il primo europeo a gettare le ancore nella baia di Hudson e a mettere il piede là dove sorgerà l’immensa città di New York; a proposito, sarai forse interessato a sapere che le due erte collinette da te descritte, oggi si chiamano Staten Island e Brooklyn. Ma, francamente, tutto ciò è avvenuto per caso: non potevi certo immaginare che New York sarebbe sorta proprio lì, né vedo un collegamento con la tua “scoperta” e la nascita di quella grande città. E poi, quanto sei rimasto in quella baia? Dodici o, al massimo diciotto ore: una visita un po’ affrettata, non ti pare?”.Giovanni da Verrazzano si sentì perduto: era convinto che l’aver gettato le ancore nei Narrow e l’aver solcato per primo le acque della Upper Bay fossero motivi più che validi per la riconoscenza del genere umano. Ma Giovanni era un navigatore esperto e testardo: “Anche Colombo si imbatté per caso nell’America, pur essendo ben convinto di trovarsi in India.
Manhattan? Venne venduta dagli indiani a un olandese per 60 fiorini
E poi come non considerare che proprio quella penisoletta da cui si dipartivano gli indiani per venire a festeggiarmi, appena 100 anni più tardi avrebbe avuto un preciso valore commerciale, 60 fiorini che l’olandese Peter Manuit sborsò agli indiani Canasci per l’acquisto di quella che sarebbe diventata Manhattan. Forse il primo, se non addirittura l’unico esempio di occupazione pacifica di un territorio, basata solo su amichevoli accordi commerciali”. “L’olandese si chiamava Minuit, con la i” si limitò a puntualizzare la storia, continuando a scorrere con indifferenza gli appunti che aveva davanti. Verrazzano aveva ormai dato fondo a tutte le proprie risorse e incominciava a pentirsi di aver accettato quell’invito così imbarazzante, quando riaffiorò nella sua mente un particolare della sua vita che era rimasto sino ad allora ignorato.
Il corsaro Juan Florin e Verrazzano non erano la stessa persona
Si fece forza, rialzò la testa e disse orgogliosamente gonfiando il petto: “Io sono stato il corsaro francese Juan Florin. Tanto per citarne una, nell’estate del 1524 ho catturato una nave portoghese di ritorno dall’India con un carico che ha fruttato 180.000 ducati: nella mia vita ho saccheggiato o affondato più di 150 navi spagnole o portoghesi!”. Prese fiato e guardò fisso negli occhi la storia per misurare l’effetto delle sue parole, convinto di aver sferrato la stoccata finale, il colpo vincente. Ma la storia scrollò il capo sorridendo: “Sì, lo so che per secoli tutti hanno pensato che il corsaro Florin – il Fiorentino – fosse in realtà Giovanni da Verrazzano, visti anche i rapporti stretti che tu hai sempre tenuto coi francesi e con il re Francesco I in particolare. In effetti le coincidenze sono molte, a cominciare dalla società che univa quel corsaro al famoso armatore e finanziere Giovanni Ango, lo stesso che organizzò la tua spedizione attraverso l’Atlantico. Ma sono solo coincidenze: le date delle imprese del corsaro Florin non sono compatibili con quelle del tuo impegno di navigatore ed esploratore. La storia della nave portoghese catturata nell’estate del 1524, ad esempio, risulta quanto meno improbabile, visto che eri tornato solo da pochi giorni dal tuo primo viaggio lungo le coste nordamericane. Altre scorrerie del corsaro si collocano con certezza in epoche in cui tu ti trovavi altrove. Poi, che dire del figliolo Francesco che ereditò con atto notarile tutti i beni di Florin: tu non avevi figli, vero? Anche i più tenaci sostenitori della tua identità con Florin, dopo secoli di discussioni hanno dovuto infine ricredersi". Giovanni da Verrazzano era stordito e confuso; non si capacitava dell’impietosa demolizione di quello che considerava il suo punto vincente, la figura del corsaro, così gloriosa da finire per crederci lui stesso. Giovanni ripensava alla sua vita, al disinteresse – se non alla delusione – con cui i suoi contemporanei avevano salutato il suo rientro dopo l’impresa transatlantica: non aveva trovato alcun passaggio a Nordovest e nel suo racconto, sempre onesto e obbiettivo, si era limitato a descrivere la presenza nel Nuovo Mondo “di vari numeri di uccelli e molti cervi, daini e lepri”; quanto ai minerali o ai metalli, sì gli sembrava di aver visto qualcosa ma da grande distanza, da bordo della propria nave. Altro che le ricchezze dell’America spagnola! E della via abbreviata e facile verso l’India e le spezie, nemmeno a parlarne: c’era un intero nuovo continente a sbarrare la strada. Verrazzano incominciò a pensare con amarezza che lo scetticismo che sembrava mostrare la storia nei suoi confronti fosse in fin dei conti più che fondato. Decise che ne aveva abbastanza; si alzò, fece un rispettoso cenno del capo al suo interlocutore e si avviò lentamente verso l’uscita.
Verrazzano fu il primo a scrivere una vera e propria relazione sugli indiani del Nord America
“Dove vai?” lo fermò la storia con un sorriso. “Il tuo posto è qui con noi da 500 anni: Giovanni da Verrazzano è uno dei cinque più gloriosi navigatori italiani dell’era delle grandi scoperte geografiche, ammesso che abbia un senso distinguere per nazionalità questi giganti, questo vero patrimonio dell’umanità. Senti, fra i tanti che hanno definito “eccezionale” la tua impresa, che cosa dice di te l’antropologo americano Hoffman: “Fu il primo ad esplorare lo spazio ignoto fra le imprese spagnole del Sud e quelle inglesi del Nord, il primo a stabilire la natura continentale delle Americhe, il primo comandante a riportare indietro quella che si può definire una vera e propria relazione sugli indiani del Nord America”. Noi sapevamo già tutto questo, naturalmente: ci serviva solamente fare una ricognizione generale delle tue imprese, un riassunto per quelli che non sanno, un ripasso per quelli che non ricordano”.
Ad aiutare a non dimenticare Giovanni da Verrazzano (nato forse, nel 1485 nella Val di Greve, in Chianti e morto nel 1528, in occasione di una sua nuova spedizione, ucciso e divorato dai cannibali probabilmente nell’isola di Guadalupa, uomo di lettere, colto, intelligente, uomo capace di rappresentare la prosecuzione logica di quanto aveva già delineato Vespucci, l’anello di congiunzione fra la prima fase dell’esplorazione dei mari basata sulla passione per l’avventura e sul coraggio, e un’epoca più razionale, organizzata e preparata che sfocerà nell’era dei lumi e che troverà in James Cook il più significativo e autorevole rappresentante) e la sua impresa sulla quale il silenzio è durato incredibilmente sino al 1909 (quando fu scoperto il manoscritto da lui indirizzato al re di Francia Francesco I con il resoconto della sua impresa, 11 cartelle che rappresentano l’unico documento scritto sul Nord America del XVI secolo, la più antica testimonianza sulla vita, le caratteristiche sociali, culturali ed etniche delle popolazioni indiane locali, così come il più antico resoconto geografico e topografico di quel tratto dell’America fra la Florida e Terranova) ci pensa da mezzo secolo un ponte. Quello che nel 1964 i newyorkesi gli hanno dedicato, un ardito ponte in ferro che unisce, con una campata di 1300 metri, le due famose “erte collinette”, Staten Island e Brooklyn, rimediando in qualche modo alla erronea celebrazione del “primo” esploratore della baia, Henry Hudson, che vi viaggiò soltanto nel 1609. Quasi cento anni più tardi del fiorentino.
Testo di Giorgio Grosso, pubblicato sul numero 52 di Arte Navale. Si ringraziano per le immagini il Centro Studi Storici Verrazzano (www.verrazzano.org; email: info@verrazzano.com) di Greve in Chianti, istituto che promuove studi e celebrazioni del navigatore fiorentino, e il suo direttore Luigi Cappellini. www.verrazzano.org; email: info@verrazzano.com.
da Arte Navale n° 52