L'incredibile viaggio di James Cook
alla ricerca della terra che non c'è

Sul finire del ‘500 era radicata la convinzione che tutto quello che c’era da scoprire nel mondo fosse stato già scoperto, o quasi. C’era anche un po’ di delusione. Il miraggio di controllare il commercio delle spezie - che continuava a stimolare le grandi spedizioni oceaniche - si era infranto davanti alla cruda realtà: Colombo non aveva affatto raggiunto l’India, la strada percorsa da Magellano si era rivelata lunga e pericolosa, la ricerca di un passaggio a Nord Ovest si era risolta in un nulla di fatto. Non restava che la rotta tracciata da Vasco da Gama attraverso il passaggio del Capo di Buona Speranza, peraltro in aperta concorrenza con la millenaria esperienza delle carovane arabe lungo i deserti infuocati. Forse la nuova patria delle spezie si trovava in quel continente misterioso, ancora non scoperto, di cui per tanto tempo si era favoleggiato e che doveva collocarsi per forza nell’area australe del Globo, per controbilanciare la Terra ed evitare che il tutto ruzzolasse nello spazio infinito dell’Universo: ecco cosa restava ancora da scoprire, e bisognava farlo presto. Spagna e Portogallo avevano smesso da tempo di finanziare nuove imprese di "descubrimiento" e l’Olanda, dopo aver dato un’occhiatina svogliata all’Australia (che comunque aveva chiamato “Nuova Olanda”) aveva deciso di ritirarsi dalla grande competizione dell’esplorazione e della conquista, limitando i propri interessi commerciali intorno al proprio quartier generale di Batavia, in Indonesia, e lasciando il campo libero ai francesi e agli inglesi. Nel 1767, a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, l’inglese Wallis e il francese de Bougainville attraversando il Pacifico alla ricerca della Terra Australe, approdarono a un’isola lussureggiante e indimenticabile, che avrebbe lasciato il segno: Tahiti.
Venere davanti al Sole? Era solo un trucco per scoprire il Continente Australe senza essere ... scoperti
Non passò un anno che gli Inglesi, smaniosi di precedere gli avversari nella scoperta del misterioso Continente Australe e non volendo dare troppo nell’occhio, organizzarono una spedizione scientifica in grande stile, con la scusa di voler osservare un evento astronomico rarissimo: il passaggio di Venere davanti al Sole. La data ottimale era quella del 3 giugno e la posizione ideale per l’osservazione del fenomeno venne individuata proprio nell’isola di Tahiti. La spedizione fu affidata al comando di un certo James Cook. Chi era James Cook? Le cronache lo definiscono un giovanottone alto quasi due metri, con la passione per l’avventura e la scoperta sostenuta da un puntiglioso rigore per la ricerca e lo studio, tale da non lasciare mai nulla all’improvvisazione.
Evitando le "trappole" del fiume San Lorenzo, James Cook conquistò la roccaforte di Quebec e la fiducia degli inglesi
Si era guadagnato stima e galloni dopo aver scandagliato con cura meticolosa i fondali del San Lorenzo, fiume insidioso, pieno di secche invisibili e di rocce semiaffioranti, riuscendo così a sorprendere ed espugnare la roccaforte francese in Quebec, agli ordini dell’onnipresente Bougainville. Gli inglesi esultarono, comprendendo di aver per le mani l’uomo giusto, il fuoriclasse che avrebbe loro consentito di dominare tutti i mari del mondo. La nave selezionata dall’Ammiragliato per la spedizione fu la Pembroke, subito ribattezzata Endeavour. Era una nave piuttosto piccola e non molto elegante: poco più di trenta metri di lunghezza, circa dieci di larghezza, per una stazza di 368 tonnellate, ma “promette bene per viaggi di questo genere”.
Imbarcare una capra viva significò assicurarsi un po' di latte fresco...
Agli 83 uomini di equipaggio si aggiunsero l’astronomo Green e i naturalisti Banks e Solander, con numeroso seguito di servitori e di alcuni geni dell’illustrazione botanica, oltre a una capra, veterana delle precedenti spedizioni di Wallis, con il compito di fornire latte fresco durante la lunga navigazione.
... e riempire le stive di concentrato di limone salvò l'equipaggio dallo scorbuto
A proposito di alimentazione, Cook – obbedendo semplicemente al suo buonsenso – fece imbarcare notevoli quantità di malto, crauti e concentrato di limone: si sarebbero rivelati la salvezza per l’intero equipaggio, messo al riparo dal flagello dello scorbuto. Cook disse successivamente con orgoglio che, durante i tre anni del lungo viaggio, non un solo componente della spedizione era stato vittima della terribile malattia. La dotazione scientifica di bordo messa a disposizione dalla Royal Society per l’osservazione del passaggio di Venere, poteva competere – fatte le dovute proporzioni temporali – con l’equipaggiamento dei primi uomini che sbarcarono sulla Luna nel XX secolo: due telescopi a riflessione, treppiedi con assi polari adatti per osservazioni fatte all’equatore, un quadrante astronomico, un cronometro per calcoli astronomici, un osservatorio portatile e altri telescopi individuali.
A bordo c'era perfino un telescopio per osservare il fondo marino
Quanto al bagaglio del naturalista Banks, vengono citati una “macchina acchiappafarfalle” e un telescopio per osservare il fondo marino. Il 26 agosto 1768 l’Endeavour, con 106 persone a bordo, lasciò Plymouth per raggiungere Tahiti e mettere le mani sul misterioso e introvabile Continente Australe. Dopo aver doppiato Capo Horn in “soli” 33 giorni, Cook non puntò dritto verso Tahiti, ma proseguì a lungo verso ovest, spingendosi dove nessuno si era mai aventurato fino ad allora. Il fatto di non incontrare alcun continente era una prima, seppur parziale, conferma della inesistenza della Terra Australis. Finalmente giunsero a Tahiti. Con soddisfazione generale registrarono che la meta era stata colta con quasi un mese di anticipo sul previsto. L’accoglienza dei nativi fu, al solito, festosa e amichevole, ma i tahitiani mostrarono un piccolo difetto che avevano già riscontrato Wallis e Bougainville: nella allegra confusione durante la visita a bordo, rubacchiarono un po’ di tutto. “In questo sono dei veri prodigi di abilità”, annotò indulgente il capitano. “Si raccolsero intorno a noi in gran numero, con i modi più amichevoli che potessimo desiderare; solo mostravano una grande tendenza a pescare nelle nostre tasche”. L’atmosfera era così idilliaca che molti isolani si offrirono spontaneamente di aiutare i marinai dell’Endeavour a raccogliere la legna di cui c’era grande bisogno e accettarono con riluttanza un compenso. D’altra parte Cook annotò la grande attenzione con cui i suoi uomini si erano mossi: “Non abbiamo abbattuto nemmeno un albero”, scrisse, “senza aver prima ottenuto il loro permesso”. Il 3 giugno 1769 l’osservazione del passaggio di Venere davanti al sole avvenne regolarmente, ma i rilevamenti furono molto discordanti tra loro a causa dell’alone di pulviscolo che circondava il pianeta. Comunque Cook potè definire assolta la parte scientifica del viaggio e dedicarsi al vero scopo della missione. Era ormai tempo di alzare le vele, l’introvabile Continente del Sud li aspettava. Rotta per Sud e quindi diritto verso Occidente. Andando verso questa direzione Cook si imbattè, tuttavia, solo nella Nuova Zelanda. Per convincere gli scienziati di bordo, ancora ostaggi dell’idea del continente misterioso, e soprattutto per seguire la sua innata curiosità, Cook procedette metro per metro al rilievo completo delle due isole scoprendo, tra l’altro, lo stretto che le divide e che avrebbe portato il suo nome. Le coste si rivelarono sovente ostili, con forti risacche e scogli affioranti, e raramente offrivano ripari protetti.
Un Maori regalò i resti del suo pranzo a base di carne umana
L’incontro con i Maori non fu facilissimo. La loro predilezione di inserire la carne umana nel menù ne uscì confermata, con orrore, quando, durante una sosta per carenare la nave, Cook e i suoi si imbatterono in un gruppetto di locali che “poco prima dovevano essersi fatti un bel pranzetto di carne umana perché uno di loro mi diede l'osso dell'avambraccio di un uomo che era freschissimo e la cui carne era stata rosicchiata di recente”. Proprio sulla punta dello stretto tra le due isole maggiori, Cook trovò una baia ben riparata, circondata e protetta da alte montagne, ricca di acqua dolce, di legname e di viveri. Anche i maori del villaggio vicino sembrarono amichevoli e ben disposti: l’ideale per i lavori di carenaggio di cui la nave aveva urgente bisogno e per porvi una base stabile per rifornimenti e future spedizioni. Il nome prescelto per quella baia posta proprio di fronte all’insenatura che avrebbe ospitato Wellington – la futura capitale dell’intero Paese – fu Queen Charlotte Sound: “conficcammo molto bene nel terreno un palo nella parte più alta dell’isola e vi innalzammo la bandiera inglese. Poi bevemmo una bottiglia di vino alla salute di Sua Maestà la Regina”. Nel complesso l’isola del Nord fu considerata più ospitale e, nauticamente parlando, più accogliente di quella del Sud, quest’ultima dominata da un paesaggio che lo stesso Cook definì “alpino”: alte montagne perennemente innevate, nebbia e freddo, tanto freddo.
La carta della Nuova Zelanda disegnata da Cook annotava ogni anfratto, promontorio, ogni roccia
Con meticolosa cura Cook rilevò ogni più piccolo anfratto della costa, ogni promontorio, ogni roccia affiorante e tracciò la carta definitiva della Nuova Zelanda. Il 31 marzo 1770 potè considerare concluso il suo lavoro e far vela ancora una volta verso Ovest. Lasciando questa terra osservò: “Il paese è certamente privo di ogni specie di animali sia feroci sia domestici”, e profetizzò acutamente che “se questo paese venisse colonizzato da gente industriosa, ben presto produrrebbe non soltanto i generi di prima necessità, ma anche il superfluo”. Tutto vero: la Nuova Zelanda, per un fatto misterioso, non è mai stata la patria di alcun mammifero a quattro zampe e i milioni di pecore, vacche, cervi che vi vengono allevati sono stati tutti importati; i tre milioni e mezzo di industriosi abitanti hanno reso il loro Paese un formidabile competitore economico e produttivo nel mondo.
L'impresa più difficile? Disincagliare l'Endeavour dalla barriera corallina
Cook aveva esaurito la sua missione e avrebbe potuto comodamente tornare a casa ripassando per Capo Horn e, quindi, risalendo l’Atlantico. Ma già che era lì, decise di far tutto l’opposto e di tentare l’ultima, accurata verifica sulla reale consistenza della Nuova Olanda, o Australia che dir si voglia. Trecento miglia di barriera corallina, infida e micidiale, venti perennemente burrascosi, mare sempre agitato mettono tutt’oggi a dura prova le navi moderne. Ogni miglio, ogni metro fu percorso da Cook con infinita attenzione, facendosi precedere da scialuppe per scandagliare il fondo, dando in continuazione l’àncora e salpandola in un progredire lentissimo e carico di tensione. Fino a quando accadde l’inevitabile e l’Endeavour si incagliò su una secca traditrice. Sfortunatamente l’incidente accadde proprio con la marea montante. C’era quindi poco da sperare in un disincaglio spontaneo e Cook diede ordine di gettare a mare tutto quanto non fosse assolutamente indispensabile: cannoni, zavorra, barili, doghe, giare d’olio. Ma fu tutto inutile. Anche quando la marea raggiunse il massimo, mancavano ancora 30 maledetti centimetri per far galleggiare la nave. Intanto l’acqua incominciò a invadere la stiva e non bastarono le tre pompe per fronteggiare l’allagamento che divenne sempre più preoccupante. Cook si rivelò davvero bravo nel sistemare al punto giusto tutta una serie di àncore e nel mettere in forza gli argani con cavi e tiranti per riportare la nave in posizione di galleggiamento, ma fu assalito dal dubbio atroce che l’Endeavour potesse colare a picco non appena liberata dalla secca che fino a quel momento l’aveva trattenuta. Nel suo diario confessò: “Fu un momento allarmante, potrei dire terribile, incombendo su di noi la minaccia di naufragio appena la nave avesse ripreso a stare a galla”. Ma alla fine la nave, con sinistri scricchiolii, incominciò lentamente a liberarsi dalla morsa del fondo sabbioso e a galleggiare tra l’entusiasmo generale. Cook, dopo 24 ore filate di spasimo ed essersi complimentato con l’equipaggio (“non avrebbero potuto comportarsi meglio”) potè dirigere verso un’insenatura protetta per lasciare ai carpentieri il compito di sanare lo sfregio nel fasciame.
Cercando una baia dove poter riparare la nave Cook approdò là dove sarebbe sorta Sydney
Dopo aver visitato una grande, bellissima baia ricca di piante sconosciute che fecero andare in estasi il naturalista Banks al punto da convincere Cook a chiamarla Botany Bay (la splendida baia nei pressi della quale sarebbe sorta Sydney), la navigazione procedette verso Nord all’interno della barriera corallina. Fu una navigazione pericolosa e difficile, attraverso le mille insidie del dedalo di rocce affioranti e banchi di corallo dove, una volta entrati, è spesso difficile trovare il canale sicuro per uscire. Alla fine Cook, sfinito, affibbiò a un promontorio posto quasi in cima all’Australia, dopo tante fatiche e tante paure, il nome significativo di Cape Tribulation. L’obiettivo, ora, era Batavia, che l’Endeavour raggiunse il 5 ottobre 1770. La nave fu subito vittima della burocrazia e dei taglieggiamenti tipici dei grandi centri commerciali. “A Batavia si possono avere viveri freschi, provviste di ogni genere, attrezzature per navi, eccetera; ma vi sono pochi articoli che non abbiano prezzi altissimi, specialmente se li comprate dalla Compagnia. Batavia non è certo il paradiso per chi viene dall’Europa; se si sarà costretti a toccare questo porto, sarà bene di cercare di abbreviare il più possibile il soggiorno”. Finalmente, sabato 13 luglio 1771, l’Endeavour rientrò in patria, nel porto londinese. Asciutto ed essenziale come sempre, James Cook annotò. “Alle tre del pomeriggio ancorammo nei Downs e poco dopo sbarcai per recarmi a Londra”. Dove stava andando Cook così di fretta quel sabato pomeriggio? Si può scommettere che la sua destinazione fosse la sede dell’Ammiragliato, dove intendeva esporre il piano di un nuovo viaggio alla caccia del Continente australe. Il progetto, nelle sue linee essenziali, prevedeva una traversata in senso contrario rispetto alla precedente, ossia da Ovest verso Est, a una latitudine più alta, la più vicina possibile alla zona dei ghiacci antartici, e la costituzione di una base stabile in Nuova Zelanda. Solo così, a suo avviso, “l’esplorazione del Pacifico sarebbe stata completata”.
Il primo pensiero appena sbarcato a Londra? Ripartire, per completare l'esplorazione del Pacifico...
La risposta dell’Ammiragliato fu entusiastica e immediata. Vennero acquistate due navi, ribattezzate Resolution e Adventure, più grandi e capienti dell’Endeavour, e si iniziarono subito i lavori di adattamento dei velieri alle esigenze della lunga navigazione secondo le istruzioni di Cook. L’equipaggio venne composto in gran parte dagli stessi veterani del primo viaggio, scienziati compresi. Il 13 luglio 1772, a un anno esatto dalla conclusione dell’impresa precedente, la piccola flotta salpò da Plymouth per un viaggio che sarebbe durato tre anni.
... con a bordo un ospite d’eccezione: il primo cronometro marino
A parte nuovi astronomi, nuovi pittori e nuovi naturalisti, a bordo c’era un ospite d’eccezione: il primo cronometro marino (“nostra guida infallibile”, lo avrebbe definito Cook), frutto della genialità di John Harrison. Seguendo il suo intuito, che lo spingeva a cercare il chimerico Continente a Sud, Cook si diresse anzitutto verso la banchisa polare dove incontrò “burrasche violente” e molte “isole di ghiaccio”, col termometro sempre sotto lo zero “tanto che il cordame e le vele erano costantemente incrostati di ghiaccio”. Le due navi procedettero appaiate prima verso Ovest, poi verso Est, in una nebbia fittissima e sfiorate costantemente dagli iceberg. Il mare era impressionante e il vento costringeva i due comandanti a procedere con velatura ridotta.
17 gennaio 1773, il giorno in cui venne attraversato il Circolo Polare
Ma James insistette per inoltrarsi pericolosamente nella banchisa alla ricerca di un varco che lo conducesse alla terraferma e il 17 gennaio, per la prima volta nella storia, attraversò il Circolo Polare. Ad appena 75 miglia da quello che in realtà è il Continente Australe, le due navi si persero di vista. Lo spettacolo “strano e romantico” degli iceberg, resi “più imponenti dallo spumeggiare delle onde e dai marosi che vi si frangono contro può essere descritto solo dal pennello di un abile pittore per l’ammirazione e l’orrore che provocano”; l’equipaggio aveva le mani piene di geloni e la situazione stava diventando troppo pericolosa per la nave e per gli uomini. James decise allora di puntare di nuovo verso Tahiti e, successivamente, alle Tonga, dette le Isole degli Amici, “tutto un giardino”, dove il re è quello più grosso di tutti.
Fuggendo dai ghiacci la Resolution e la Adventure si persero di vista per non ritrovarsi mai più
Ma una violenta burrasca allontanò ancora una volta le due navi l’una dall’altra: non si sarebbero mai più ritrovate. Cook, con la Resolution, si buttò ancora a perlustrare la banchisa, in rotta verso Est, superando nuovamente il Circolo polare, in mezzo a “duecento iceberg”. Per fortuna quel giorno non c’era nebbia perché altrimenti “soltanto un miracolo li avrebbe tenuti alla larga”. Ora il grande esploratore sembrava forsennato nel suo frenetico setacciamento del mare: procedeva a zig-zag con l’idea precisa di non lasciare nessuna area inesplorata nella immensa rete che stava disegnando. Per un anno intero continuò ad andare su e giù, a destra e a sinistra, verificando, correggendo, cancellando tutte le precedenti rilevazioni geografiche con tutte le loro approssimazioni e fantasie. Il 26 gennaio 1774 passò per la terza volta il Circolo Polare Antartico, poi tornò a Nord verso l’isola di Pasqua e Juan Fernandez. Poi ancora verso Ovest, dove toccò le Marchesi, le Tuamotu e, nuovamente, Tahiti; quindi Tonga, Vanuatu e la Nuova Caledonia. Una breve sosta a Queen Charlotte Sound, poi ancora un tuffo nella banchisa polare, questa volta lungo il settore atlantico. Finalmente, nel febbraio 1775, James Cook si arrese all’evidenza di quanto aveva già intuito da molto tempo. Con la consapevolezza di chi ha la coscienza a posto, registrò sul suo giornale di bordo, che “avevo fatto il giro completo dell’Oceano meridionale in alta latitudine, traversandolo in modo tale da non lasciare il benché minimo spazio per la possibile esistenza di un Continente”, e soggiunse: “Se ho fallito nella scoperta di un Continente, è semplicemente perché non esiste (...) e mi lusingo che si sia posta la parola fine alla ricerca di quel Continente Australe che ha attirato l’attenzione di alcune potenze marittime per quasi due secoli, e quella dei geografi di tutti i tempi”.
Alla ricerca del passaggio a Nord-Ovest trovò la morte, ucciso da un indigeno delle Hawaii
Cook morì il 14 febbraio 1779, ucciso dagli indigeni delle Hawaii nel corso del suo terzo viaggio (questa volta alla ricerca del passaggio a Nord-Ovest), a seguito di una scaramuccia causata da una serie di errori e di equivoci: proprio lui che aveva fatto del rispetto delle tradizioni e della libertà dei locali un dogma assoluto, una religione. Il migliore epitaffio sta nelle parole di un vecchio capo maori della Nuova Zelanda. Egli raccontò che quando era bambino aveva visto arrivare nella baia una grande barca con un gruppo di spiriti bianchi. “Su quella barca c’era uno superiore a tutti. Noi capimmo che era il Capo Supremo, per il suo perfetto portamento gentile e nobile. Lui parlava poco, ma qualche altro spirito parlava molto. Questo però non pronunziò molte parole; non fece che prendere in mano le nostre stuoie e le armi e accarezzarci la testa”.
Testo di Giorgio Grosso pubblicato sul numero 54 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale.Le immagini sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. E' fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall'autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.








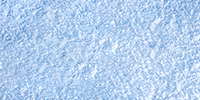



























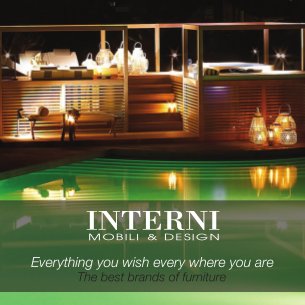






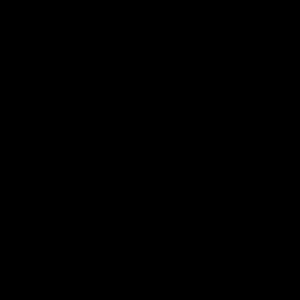







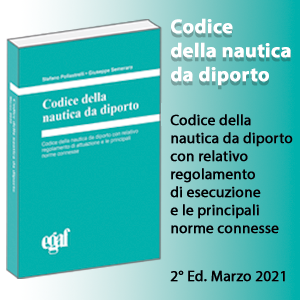

I commenti sono chiusi